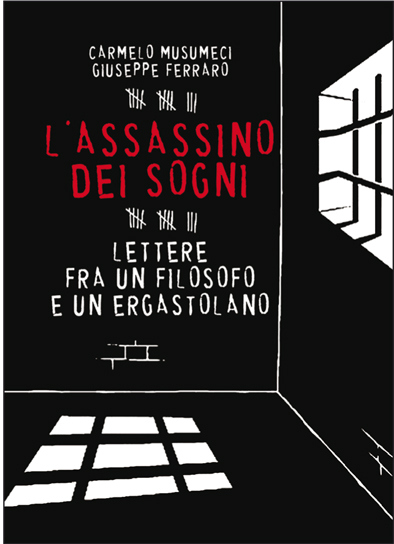Bambini in filosofia
Ottobre 17, 2014 Posted by gf Eventi 0 thoughts on “Bambini in filosofia”
L’Arte della Felicità compie 10 anni. Entra nella fase dell’adolescenza, la più inquieta, incerta e vera. L’intervento che propongo quest’anno riguarda i legami di separazione. Ogni legame ne è espressione, tiene insieme i separati. Sarà allora da intendere una tale manutenzione, come tenersi per mano, come intendere il gesto della parola come mano che accompagna attraversando un cammino. L’arte della felicità è la stessa del legarsi, del tenersi nelle proprie separazioni, lacerazioni, frammenti. È anche come separasi senza lasciarsi o, che è lo stesso, come lasciarsi senza separarsi. Nessuno è libero da solo: La libertà è fatta di legami. Il grado della di ognuno libertà si misura dalla qualità dei propri legami.
Istituto Italiano Studi Filosofici, 2 ottobre 2014
La felicità e i legami di libertà
Dunque la felicità è un’arte?! Ci ritroviamo ogni anno all’appuntamento di questa manifestazione che avanza a passi di eventi straordinari, con conferenze e azioni che occupano la città, L’arte della felicità appunto. Confesso che è il solo appuntamento al quale arrivo con appunti scritti, che non leggerò, sia bene chiaro, non ne sarò capace, si parla a chi ci si rivolge e che nel suo ascolto suggerisce vie e indicazioni per una strada che si fa insieme. Devo perciò ringraziare Francesca Mauro e Luciano Stella che danno in questi giorni con questa loro manifestazione, un respiro di felicità alla città che ne ha bisogno, ancora di più in un momento in cui viene presa d’assalto d’assalto la sua Amministrazione.
Dunque la felicità è un’arte?! È una domanda ed è un’esclamazione. Non posso distinguere un tono dall’altro. Resto sospeso tra l’esitazione e la convinzione che sia così. Ogni domanda è un’esitazione di risposta. Chi pone una domanda è sempre sul punto di dare una risposta, aspettando che l’altro al quale si rivolge l’accolga e concordi con quel che si ha bisogno di sapere. Ogni domanda è rivolta dapprima a sé, per poi rivolgersi a un altro e ritornare in se stessi a convincersi di quel che s’intendeva o cambiare prospettiva di pensiero. In genere non si è mai pienamente d’accordo con le risposte che vengono dagli altri, si accolgono con stupore o con il verso pensoso del rimuginare, Uhm.
Quindi ancora: la felicità è un’arte?! Diciamo che è l’esclamazione di una domanda o l’arresto improvviso della domanda su se stessa, dovuto alla sorpresa dell’interrogarsi sulla felicità come arte.
Di quale arte allora si parlerà? Si può dire dell’arte del costruire, del dipingere, del navigare, dello scolpire … l’arte rimanda a un sapere e alla sua applicazione, perciò l’arte della felicità è di chi sa cosa è la felicità, conosce le istruzioni di base, i fondamentali, e i modi in cui si realizza quel sapere.
La facilità del fare e la felicità dell’operare
Noi siamo al tempo delle “app”, anche l’arte è catturata nell’agevolazione delle “app”. Confesso che quando si comincia a usare l’espressione “app”, non capivo che cosa s’intendesse, ne mi permettevo di chiederlo perché si dava per scontato saperlo, e dare per scontato significa che sei non sei fuori tempo, che non stai fuori del mondo com’è attuale adesso. Allora non chiedevo, restavo ai margini del mondo. Poi ho capito, “app” sta per “applicazione”. Magari ci sono pure di quelli “attuali” che non sanno di questo passaggio. Chi lo riconosce può anche lamentare una tale riduzione, che non è solo un’abbreviazione semantica, perché l’“applicazione” che ha tanti significati d’impegno proprio a scoprire, guardare, osservare, esaminare, operare e dare il proprio tempo.
Quale sarà dunque l’“app”, l’agevolazione della felicità. Qui però si afferma subito per via una distinzione. L’“app” facilita. Riguarda il fare. L’arte invece riguarda l’operare. Non possiamo scambiarli. L’arte del medico non è semplicemente fare medicina. Anzi, non basta sapere la medicina, ma bisogna che si sappia “di” medicina, che se ne porti il sapore, la si deve tenere addosso la medicina, viverla, essere medico. Ho conosciuto tanti che laureati in medicina sono invece registi, fotografi, insegnanti. Anche all’università si dice “faccio medicina”, “faccio filosofia”, “faccio ingegneria”, sostenendo gli esami in materia, ma poi certo non si è medico o ingegnere, nemmeno una volta raggiunta la laurea. Bisognerà sostenere altre verifiche e anche allora ci sarà sempre un passaggio nuovo da sostenere. Ci sono poi di quelli che sono medici pur non avendo conseguito il titolo, perché la teneva dentro la medicina già prima come desiderio e attenzione, come studio e passione. L’arte viene quando altri diranno che è uno è proprio un “artista” nel suo mestiere. L’arte reclama la singolarità dell’opera. Anche l’arte della navigazione reclama un artista. L’arte si distingue dal mestiere proprio perché non è un fare abituale, non è banale. Si dice anche di cose che sono fatte a opera d’arte, cioè rispettando perfettamente lo stile di quell’arte come la si attende in opera. Artista è chi esprime uno stile di quell’arte. Dunque anche la felicità come arte dovrà riferirsi all’opera e allo stile, ad un’espressione di sé. Si dice anche dell’attore, che è un’artista e non più semplicemente un interprete di ruoli. Si dice nella nostra città di una persona che è un artista nel suo campo, per dire di un’unicità. L’attore è un artista quando interpreta un personaggio in maniera del tutto singolare, al punto da non lasciar distinguere se stesso da ciò che interpreta ed esprime, né si può confondere con altri. L’artista è solo. Vive anche una strana solitudine. Ci sarà perciò anche la solitudine di chi è felice, vedremo come sarà, se si può dire la solitudine del felice.
Chi è felice è dunque solo? Certo, è felice chi non confonde se stesso con altri ed è indistinguibile da se stesso, chi fa della propria vita un’opera d’arte. Felice è chi avanza nella banalità del quotidiano con un passo danzante dell’animo, chi è strano o come sono per strada le ragazze innamorate che avanzano sorridenti e illuminate in volto o come lo sono i ragazzi innamorati che si abbandonano a gesti stravaganti e goffi quando l’animo in pieno scompone i movimenti del corpo.
L’arte di se stesso
“Impara l’arte e mettila da parte”, si diceva un tempo, come mi faceva ricordare ieri un’amica. Impara l’arte e mettila da parte, perché ti servirà in tempi di difficoltà, quando ci sarà una crisi, quando il bisogno supererà le condizioni di agio. “Impara l’arte e mettila da parte”, si diceva. Ed è un’espressione che suscita qualche irritazione, perché è come ammonire di fare qualcosa che non ti serve adesso, che è senza alcun valore quando tutto va bene, quando stai bene. Devi però impararla ed è quasi una minaccia per i tempi di difficoltà che arriveranno. Quell’arte servirà perciò a badare a se stessi, da soli. Basterà a renderci autonomi, indipendenti, capaci di fare quello che pochi o nessuno saprà. L’arte rimanda a un’autodeterminazione, a un’autodisciplina, rimanda a se stessi, a saper essere se stessi. Ed è felici chi sa essere se stesso?
Ripeto: la facilità del fare non è la felicità dell’operare. Fare le cose facili non basta a dare felicità. L’arte rivela lo scarto tra il fare e il dare. Io non sarò felice quando farò me stesso, ma quando darò me stesso. È una distinzione che riguarda il bene e il male. Ne discutevamo giusto in carcere, a Sulmona. Si parlava del bene. E c’era chi diceva che faceva del bene agli altri, attivandosi a dare aiuto a chi ne aveva bisogno. In carcere si arriva a conoscere il grado zero della condizione umana. In carcere si vive nelle condizioni del male. L’umanità in carcere è perduta. È dentro il carcere ci finisce chi l’umanità propria l’ha smarrita, perduta o mai avuta. Si cerca allora di comportarsi bene e si cerca di fare bene con impegno per ciò che si è perduto e ritrovato, come un cammino che comincia a fare a ritroso, compulsivo, stando sempre allo stesso punto che ha segnato per sempre la propria vita.
Allora, quel giorno, mi è venuto da mettere al centro del nostro dialogo la distinzione tra bene e male. Il bene non si fa, il bene si dà. È il male che si fa. Se si fa il bene c’è qualcosa che porta chi lo riceve a sentirsi nel bisogno, nella difficoltà, e chi lo fa ha una ragione per farlo, nascosta o chiara a se steso, seppure non detta. Il bene non è qualcosa che si fa, si possono fare bene le cose, ma non sempre è bene quello che si fa. Anche il male si può fare bene, ma non è certo bene farlo. È un dialogo difficile questo, perché arriva a un’affermazione decisiva: il male si fa, il bene si dà.
La gratuità del bene
Il male si fa, ci facciamo male e chi fa, comunque attraversa il male. Anche l’amore non si fa, l’amore si dà. Quando si fa l’amore s’intende il rapporto sessuale, si può fare bene o male, ma quel “bene” è avverbiale, non è valoriale. La facilità del fare non è la felicità dell’operare. Fare bene l’amore rende soddisfatto chi pensa di riuscirci, ma dare amore rende innamorato chi lo riceve e chi lo dà. Il dare è proprio dell’operare, il fare è proprio del definire.
Ci facciamo male, il fare come tale passa per le rive del male. Qualunque cosa si faccia, ci sarà del male da spiegare. Il male è banale, anche chi semplicemente lo sospetta in altri è banale. Hannah Arendet lo ha indicato in maniera lapidaria parlando della “banalità del male”. Il male è banale, quotidiano. Banale è quello che fanno tutti e che tutti possono fare. Non c’è nulla d’eccezionale. Diversamente dal bene. Alla banalità del male si oppone la gratuità del bene.
C’è un rapporto tra la gratuità e l’arte. Quell’“impara l’arte e mettila da parte” suggerisce come l’arte sia qualcosa di non utile da subito o d’inutile per sempre. La felicità cade sul versante dell’eccedente. Non si vive di felicità, ma quando si è felici, la vita è più vita. Ecco, siamo su questo giro di gratuito, inutile ed eccedente. L’opera d’arte contiene il gratuito, l’inutile, eccedente. L’arte supera il mestiere, eccede. Non si vive di arte, ma quando la vita è arte diventa un’altra. Non è certo utile l’arte, anzi, non è per nulla necessaria, ma l’opera che ne viene è quel di cui non si può fare a meno. A voler raccogliere come vertice estremo dell’inutile, dell’eccedente e del gratuito è la bellezza.
Col tempo ho imparato che le cose inutili sono importanti, quelle utili sono necessarie, tanto più se rendono possibili quelle importanti. Il rapporto è tra bisogno e desiderio. Il desiderio è inutile, eccede, è anche gratuito. È il desiderio che misura la qualità del soddisfacimento del bisogno. Il desiderio non si soddisfa. Il desiderio si libera. Esprime la libertà. E se, come ripeto spesso, la libertà è fatta di legami e che il grado di libertà di ognuno, come anche di un paese, è dato dalla qualità dei legami personali e sociali, ci saranno legami che imprigionano e legami invece che liberano. Ci sono legami che liberano il proprio desiderio di vivere e sono questi i legami di libertà. Il desiderio non è senza l’altro che lo suscita. Alla fine è l’altro che desiderio Desidero il desiderio dell’altro. Desidero il suo desiderio. Desidero il desiderio attraverso l’altro. La vita, questo desidera la vita. Il desiderio non è più che il sintomo riportato al mondo dell’istinto, fattosi voglia e diventato desiderio, per dirsi amore. Amo il tuo desiderio di vita, quello che susciti in me amandoti, quello che mi fai sentire dentro, sull’animo, “epithumia” come si legge del desiderio nel Filebo.
Non desiderio altro che te, sei tu che mi rendi felice. Nessuno è libero da solo. La libertà è fatta di legami. Anche la felicità è fatta di legami, nessuno è felice da solo, per quanto la libertà ci renda solo, per quanto la felicità ci mette nella solitudine in gioia, la stessa che è dell’artista e della persona libera. Si desidera l’altro per il desiderio che ci suscita il suo desiderare. Ci contagia la vita. Ci porta alla vita nella vita che abbiamo. Il suo farci sentire l’eccedenza della vita che vibra, pulsa e batte in noi come respiro. Alla fine è così: respiriamo le persone, ci sono di quelle che ci tolgo il respiro, che ci soffocano e ci sono di quelle che ci liberano il respiro, ci fanno respirare a pieno animo, sono le stesse che accendono il desiderio e che amiamo. L’arte, la libertà, il legame, la felicità ha a che fare con questo desiderio. Ed è l’eccedente, l’inutile, il gratuito, l’arte.
La scienza felice
Si dice che la felicità dura un momento. Sarà allora come apprendere l’arte del momento, l’arte dell’attimo che rende felici. La lezione di Nietzsche parrebbe un buon viatico a raggiungerla. Contro ogni pessimismo Nietzsche faceva valere il nichilismo come stravolgimento di tutti i valori. All’inizio del suo Zarathustra poneva le tre metamorfosi, del cammello, del leone e del bambino. Il cammello sopporta ogni peso e ogni male, lo carica sulla propria coscienza. Il leone è lo spirito della libertà che tuttavia non riesce ad imporre con proprio coraggio la sua volontà. Il bambino è il “sì” alla terra, il “sì” alla vita. Il bambino non è più animale e non è ancora uomo. I bambini sono i più vicini all’inizio della vita, sanno della gratuità del bene. Il bambino è chi non ha nulla da donare ed è egli stesso un dono. È da qui che inizia il cammino di Zarathustra verso un’interpretazione del sapere che non sia quello consumato del già stato e così deve essere, ma quello che permette di ritrovare il proprio gesto, presente e fungente nell’attimo dell’eternità, senza tempo di durata concesso alla gravità come al fato. La propria volontà è quel che ha deciso lo stesso che non si può rimuovere. Il bambino di Zarathustra è lo stesso bambino di Eraclito che gioca ai dadi e fa svolgere le vicende del mondo a caso.
Nietzsche arriva al suo Zarathustra dopo aver scritto “La scienza felice”, die fröhlische Wissenschaft, richiamando nel sottotitolo la scienza dei cantori provenzali, la “gaia scienza”, che nella traduzione italiana è diventato poi il titolo dell’opera di Nietzsche, facendo perdere quel senso esplicito di “scienza felice”. Bisognerà forse interrogare le sue pagine per capire come la felicità possa essere un sapere o come modificare il nostro sapere per essere felici.
Nietzsche ha inaugurato un percorso ripreso da Heidegger come Foucault e da buona parte della letteratura che cerca di trovare rimedio a una forma di sapere corrente, cercando di decostruirlo o di archiviarlo per giungere ad un pensare che non sia sottomesso ai codici d’istruzione corrente richiamandosi piuttosto all’impensato del sapere.
L’arte è invocata non a caso da Heidegger come da Foucault a trovare vie differenti dal sapere corrente, per usare la pratica di Derrida che si muove anch’egli lungo questa via. L’arte della felicità è l’arte della filosofia, la sua applicazione. La felicità è il fine dell’etica, per quanto si tratta di un’etica posta al di fuori della tradizione dei valori ai quali è stata fin qui consegnata come a dei principi da seguire e perciò prescrittivi per un sapere che arriva dopo come l’esame di un misfatto e la sua costruzione.
Cerco di tenere il percorso di questa riflessione che scrivo qui in forma di appunti ma che è una meditazione che si compone nel silenzio della voce propria. Anche di chi potrà forse leggere queste note.
L’artista è tale quando il suo non è un fare, ma un operare. L’artista non produce, genera. Non riproduce. È un’artista nella singolarità del suo essere quel che è. Nella singolarità del suo stile. L’artista mette in opera. Genera l’opera, che è tale quando sfugge alle sue mani. L’opera d’arte abbandona presto il suo autore, si legge ne “La Genealogia della Morale” di Nietzsche. L’opera d’arte abbandona presto i suo autore. L’artista resta incredulo davanti alla sua opera. Non saprebbe riprodurla. Contende l’arte con la materia che lavora e che si lascia guidare o fa ostacolo alle sue mani e ai suoi pensieri, procurando inattese e improvvise deviazioni. L’artista è chi si compromette con la vita, come in amore gli amanti si contendono il primato di chi ama di più l’altro, lungo quell’inseguimento dell’“io di più” C’è una strana solitudine in chi ama veramente. La solitudine della gioia. Il non riuscire a dire quello che prova, facendo l’esperienza dell’inciampo della parola che non riesce a dare suono alle emozioni del corpo proprio. L’artista resta incredulo davanti alla sua opera, è singolare, non può riprodurla. Prova a dominarla dicendoci non soddisfatto della sua realizzazione. Mente. È così, certo, ma non è vero. L’artista si trova di fronte alla sua opera come a qualcosa che non sa ripetere, non la sa fare.
Il non artista può farlo, perché si affida a quel modello, non riesce a liberare il desiderio che pure trattiene in sé dell’arte. Chi riproduce scambia il proprio desiderio dell’opera, lo scambia, lo sbiadisce, sostituendo il pericolo dell’incerto avanzare che ogni desiderio apre alla quiete riproduzione del già fatto. Chi copia perde il suo desiderio nell’altro, non desidera l’altro che è del desiderio nell’altro che lo suscita. Il desiderio si libera. S’incontra nell’altro, anche nell’opera che gli si fa innanzi come impropria, sua e non di sé. Chi sa riprodurre, non conosce il sapere del desiderio.
È il testo a denunciarlo, è la materia, sono i colori e i toni a manifestare il furto d’opera. Eppure noi viviamo in un tempo del “copia e incolla”, dove finanche i documenti di amministrazioni e compiti si riproducono da altri spegnendo il desiderio della singolarità del proprio esprimersi, perdendo, in nome della facilità del fare, la felicità dell’operare. Noi scambiamo il facile con il felice, anche l’amore facile viene scambiato per quello felice. Non siamo autori di noi stessi, non generiamo noi stessi quello che siamo. Bisogna porre anche qui l’attenzione sulla questione della cosiddetta mancanza di futuro, del conflitto tra generazioni e delle identità di genere. Il genere si dà nella singolarità della persona che lo esprime. Il genere uomo è nella singolarità della sua espressione individuale che trova conferma della sua generalità. Lo steso per una donna come di ogni altra identità di genere che è tale nella singolarità di chi l’esprime. Voglio pensare, nella felicità di chi l’esprime.
Proprio e improprio
Dunque la felicità è un’arte, quella di fare di se stessi un’opera. La singolarità di un genere. Il punto adesso è questo, se l’opera d’arte abbandona presto il suo autore, gli si dà come impossibile, anche a diventare di sé un’opera ci si trova abbandonati da se stessi. L’artista fa quello che per altri è impossibile, ma nel momento in cui opera l’impossibile lo rende possibilità nell’eccezionalità della propria singolarità. Bisogna riflettere sulla singolarità dell’artista che non è individualismo o egoismo, anzi sono queste le malattie dell’artista quando non è più in grado di generare. Ci sono di quelli che compiuta un’opera non riesco più ad operare, si fermano, restano nell’incapacità di dare vita a una nuova opera, e spesso perché non riesco a liberarsi del suo abbandono, ne fanno una proprietà, ne restano prigionieri per proprietà di ciò che non vuole essere proprio. È una lotta interiore, difficile.
La singolarità è un’eccezione tale che rende impropri a se stessi. Se l’opera abbandona il proprio autore, anche la singolarità di se stesso abbandona il proprio sé. Mettiamo il caso di un’artista del gioco del calcio come Maradona, la sua opera non è più di sé, ma di ognuno, di tutti, dell’ammirazione che ne viene nell’assoluta singolarità della sua espressione. Singolarità e gratuità si corrispondono. Si ritrovano nella gratuità del bene e nella singolarità dell’opera.
Che importa del signor Nietzsche si legge nella prefazione alla Scienza felice di Nietzsche. Non importa il signor Nietzsche, importa l’opera, quella che si esalta, in noi stessi alla sua lettura. Nietzsche è il nome di un’opera. Un corpo scritto e vivente in ogni lettura che lo fa vivere in un altro. Chi legge comprendendo il testo avverte questo corpo a corpo con il testo. È troppo banale, cioè fa male, distinguere il sentimento dal sintomo, come il segno dal significante. I sentimenti sono espressione del corpo che è nell’anima. Questa inversione, il corpo nell’anima, dovremmo cominciare a capire per giungere all’arte della felicità. Chi è felice sente il proprio corpo come nell’anima.
Il proprio e l’improprio, allora. Il corpo ed io. Il mio corpo e io che non lo vedo ma che mi sento vivere in esso. Es denkt, si legge in “Al di là del bene e del male”, es denkt, non io penso e non ich denke, non io penso. Il corpo è l’es. Almeno è il corpo il campo e il testo su cui “si” scrive. “corpo” non è che il significante di “esso” che è significante di qualcosa d’impersonale. Per paradosso posso scrivere che “es” è personale dell’impersonale, il proprio dell’improprio. L’es è il pronome personale dell’impersonale “si”. Tutto si da in questa identificazione del proprio dell’improprio. Ci muoviamo in questa significazione costante quando cerchiamo di sapere, fino al punto in cui si arriva a questo crocevia e ci si trova tra l’“es” e il “si”, tra il corpo proprio che è improprio che siamo e abbiamo. Voglio anticipare subito un passaggio: è felice chi arriva a unire l’es e il “si” nel “sì” esclamativo della gioia. C’è da riflettere in chi dice “Sì”. Di sicuro chi è felice dice “Sì” senza che sia rivolto a questa o quella cosa, ma “si dà” veramente, interamente, in quel momento. Accade anche in quel “ha detto sì” dicendo della persona che accettato di custodire il proprio desiderio d’amore. Lo si dice anche di un figlio. “Sì”, pronunciato in un grido prolungato dai ragazzi è l’espressione della gioia del desiderio liberato quando accade quel che si pensava non potesse succedere. È il “sì” fiero di vita.
Attenzione, l’opera d’arte è questa compromissione di corpo a corpo, quello interiore e quello esteriore, se si vuole dire così, da una faccia alla altra, quella della vita e del mondo. Il corpo è giuridico, identificativo, significante, ma corpo io sono come tutto è corpo che si muove e si agita ed è vita. Corpo io sono come vivente. Il corpo è proprio solo quando è morto, rispose una ragazza quando richiedevo di rispondere in aula alla domanda di quando il corpo è proprio. Ed è così, il corpo è proprio solo quando è morto, diventa simplice significante, si riduce a nome, cognome e data. Allora è solo proprio, non è più proprio e improprio. Ha perduto il rapporto con la vita che è nell’improprio della sconosciutezza, della riduzione a mondo. Penso in questi casi all’opera del mio Husserl che ha provato a intendere la riduzione fenomenologica non come la riduzione della vita la mondo coi suoi significati, ma una riconduzione del mondo alla vita. Resterà sempre un mio maestro per questo. Il suo fu il tentativo di attingere al mondo della vita, al mondo nella vita.
Il corpo è proprio solo quanto è morto, solo quando resta solo. Anche un amore muore quando resta solo proprio, senza l’improprio che viene dall’altra, dall’altro.
Perduto, abbandonato. Come opera. Non sapremo mai abbastanza dell’opera della vita se siamo noi a generarla o se siamo noi stessi a esserne generati, essendo opera di un artista che abbiamo abbandonato. Usiamo dire “creazione” riferendoci al mondo come creato da parte di un dio. La creazione la diciamo ugualmente per l’arte. Se dunque l’opera d’arte abbandona il suo autore, anche il creato ha abbandonato dio, il mondo è degli uomini che ne fanno parte e che devono essere, a propria volta, artisti, interpreti, di questa creazione. Bisogna ritornare al divino. Si ritorna al divino quando “si” crea. L’opera è quel che non ci aspettava che venisse e che quando viene è quello di cui non si può fare a meno. “Opus” in latino indica le cose necessarie. E ancora indichiamo con “opus” romano quell’ordine di costruzione di mura a reticolo che hanno insieme la forza del sostenere e la bellezza dell’operare. “Opus est” ci hanno insegnato a scuola: “è necessario” era la traduzione.
Certo l’uomo crea dio a propria immagine, ma prima c’è stata quest’altra creazione, la gratuità della vita di cui siamo, e il nostro “creare” artistico deve tenere conto di questa creazione, restituirla con la propria, in un corpo a corpo, in un vita a vita, la propria che si ha e l’impropria che si è.
Il vero e l’intero
L’arte della felicità è la filosofia. Quella che chiede di un altro sapere, che sta in mezzo, affacciato sull’abisso che si apre tra il mondo e la vita.
Il sapere che pratichiamo è postumo, arriva dopo, come sul luogo del delitto arriva dopo l’ispezione giudiziaria che certifica l’accaduto, dopo il fatto. Questa riduzione del vero al fatto curva il sapere alla certezza, gli perdere la verità. Non è sapere vero. Perché sia tale diceva il buon Hegel deve essere intero. Il vero è l’intero. Già, come essere interamente se stessi, come essere intero in un intero di cui si è parte e in cui si perde la parte, l’esserne parte, per ricavare un’appartenenza che è giuridica. Il corpo, il corpo proprio è un elemento d’identificazione giuridica o è qualcosa di non identificabile se non come vita. Accidenti questo è il punto di volta. L’altro, il corpo che mi viene incontro, tu che abbraccio, sei la vita che abbraccio e vedo, una vita nella vita, che abbraccio e sento di essere parte e di volerti interamente per volermi interamente, per vivere, per essere felice. Bisogno smettere di essere un corpo e diventare vita. Anche morire è vivere, muore il corpo si legge nel Filebo, non la vita che viene in un altro corpo ed è in altri corpi ed è qui che siamo.
Possedere
In carcere non vedo corpi d’identificazione, vedo una vita e un’altra e ancora una vita nella vita ridotta senza esistenza e che aspetta un altro mondo, un altro sapere, non perduto, che non arrivi dopo la battuta, dopo che si è perduto. I significati sono il nostro ritardo sulle cose, arrivano dopo. L’amore vero lo sappiamo quando è perduto. Allora come sapere veramente senza, sapendo, perdere che vogliamo trattenere? Non trattenerlo. Un sapere che non trattiene. Un sapere che si restituisce. Voglio ricordare Gugliemo di Scampia. Ci siamo risentiti dopo anni passati dal nostro corso di Scampia. Mi ha cercato, mi ha detto che si mi riconosceva come persona per quello che avevo detto in quel corso, che il sapere è un possesso senza proprietà, non va tenuto per sé, stretto o esibito, va restituito a chi non lo ha avuto o lo ha perduto.
A Scampia mi sono trovato non senza irritazione, corrucciato e indignato, quando ho letto quella frase sul muro delle due palazzine poste all’uscita della stazione della metropolitana e che fanno da colonne alla fine di palazzine del primo viale. Si legge, su una in italiano e sull’altra in inglese, che “basta crederci e trovi un mare di bene a Scampia”, “basta”, ma “bisogna” crederci perché di certo non c’è il “mare” e nemmeno il bene è da crederci, se non c’è. Più avanti sul colonnato del vialone detto della Resistenza si trova l’altra frase “se la felicità non vedi, cercala dentro”. Lo trovo offensivo per chi è costretto a vivere tra cementi e vialoni di controllo e di cronaca non felice. Il fatto è che poi mi trova a riflettere che la storia della felicità è anche quella della solitudine e del rifugio in se stessi. Il fine dell’etica in fondo è ritornare in se stessi, mettersi a riparo nel proprio Ethos, Sé. E l’etica viene all’attenzione, così la felicità, in tempo di crisi di benessere, che quando c’è pochi ne parlano o ne sentono l’esigenza.
Mi sono chiesto perché i filosofi insistessero sulla “conoscenza di sé” e sulla “cura di se stesso”. La stessa irritazione mi si è presentata quando ho preso a leggere per quest’occasione un libro di Shopenhauer. Non è un filosofo che rientra nelle mie preferenze di studio. Il testo è sulla saggezza della vita e inizia a parlare della felicità. Individua tre distinzione l’essere, l’avere, l’apparire. Afferma che la felicità si ha solo in se stessi. In fondo è la distinzione di sempre che attraversa la storia della felicità come dell’etica a partire dalla fine della filosofia come costruzione di mondo e di vita che si propone sul piano dell’organizzazione sociale e personale della vita comune. Nessuno è libero da solo. La libertà è fatta di legami. Anche la felicità è fatta di legami, nessuno è felice da solo.
Posso intendere allora quella distinzione tra essere, avere, apparire, tra ciò che uno è, tra ciò che uno è e quello che rappresenta, solo in ragione del mio, del di me, dell’altro. Penso alla distinzione dell’essere proprio, dell’essere per altro, dell’essere di altro o per altri. L’avere è l’espressione della proprietà, il rappresentare lo è del ruolo, il proprio è dell’in sé. Vale qui la distinzione che vale per l’amore come possesso senza proprietà. Così il sapere è un possesso senza proprietà. Tu sei mia non di me. Sei mia come neppure tu sai di essere, non sei però di me come una proprietà. Sei mia come non sai di essere. Sei la mia sconosciuta come tu non sai e non conosci come sei in me. L’amore porta questo filtro di sconociutezza che rileva il proprio e l’improprio del sé in se stesso. Siamo vita e abbiamo vita, la vita che siamo è impropria, vita come dei viventi tutti. Abbiamo vita come la propria, delle nostre scelte e progetti, è la propria esistenza. La distinzione tra vita ed esistenza è presente in tutte le lingue europee.
Tu sei la mia sconosciuta, come la vita è sconosciuta nella mia esistenza. Quante volte chi si ama dice all’altra all’altro, tu non mi conosci proprio. Tu sei la mia sconosciuta, chi va venire all’animo, sull’anima, epithumia, il desiderio.
Il vero e il velo
Come allora diventa quello che si è. Questa la domanda di Nietzche. Wie man wird was man ist, come si diventa quello che si è. Sarà questo il principio dell’arte della felicità, come essere opera, come diventare opera d’arte. Come dunque riuscire a diventare quello che si è. Cosa? È chiaro adesso: come riuscire a diventare sconosciuti a se stessi. Come amare veramente chi si ama senza farne una proprietà, senza varcare la banalità dell’appropriazione e della violenza. Come mantenere questa sconosciutezza. Come nel legame mantenere la separazione. Come amandoti non sai tu stessa come sei in me che ti amo. Mia, in me, non di me. Non so chi sei tu in te, tua. L’amore vero porta una tale sconosciutezza, perché sfugge al sapere che codifica cose e significati. Il vero amore pone un velo tra gli amanti. La verità è relazione. Non è, come si dice, dietro il velo. Il vero è il velo. Il vero fa velo di ciò che si vuole sapere. Fa velo, protegge nel non poter sapere quel che si vuole sapere. C’è un rapporto tra il desiderio e la verità. L’una si fa relazione dell’altro. È il modo in cui si esprime il desiderio, che si può dire di “volere veramente” qualcosa. Il desiderio non si soddisfa, si libera. Non si fa postumo, non resta soddisfatto, non è come il sapere che giunge dopo e si fa postumo di ciò che sa, catturandolo e imprigionando in un significato. Il desiderio si libera, stabilisce un rapporto di libertà, chi desidera libera il proprio desiderio nell’altro, stabilisce una relazione di libertà e di vita. Una libertà vera. Un sapere vero. Lo stesso che io so di chi amo veramente come mai potrà sapere chi sia e che sento chi amo. Il vero è il velo. La verità si viene sempre a sapere, quando però è saputa sfugge al sapere che la cattura. La verità in prigione rende liberi nell’innocenza. Ed è innocenza la verità. Non certo quella oggettiva o relativa, ma la propria, quella intima, facendo etimo del proprio sentire, viene dal thumos, dall’animo. L’anima è il corpo rovesciato, com’è da dentro. Non si vede e sfugge ad ogni autopsia, sfugge al proprio sguardo. Sfugge al sapere. La verità non è mai certa. L’amore vero è senza certezza alcuna, anche l’amicizia vera è senza certezza, anche la propria verità. Anche l’essere proprio. Non si lascia sapere, sfugge, diviene, si dice anche. Quella domanda di come diventare quel che si è ritorna nel domandarsi come essere vero.
L’artista sa del proprio non sapere come avviene la creazione dell’opera. Sa che l’opera d’arte, che viene alle sue mani, l’abbandona. È sua, non di sé. Chi ama veramente sa di questo scarto tra il possesso e la proprietà. Sa del desiderio e della solitudine del desiderio come della solitudine del felice. L’artista è amante. Il vero artista è il vero amante.
Il velo del vero rende sconosciuto chi si ama. Non so come sei, quel che dico amore vero e quel che è vero di ogni relazione, di ciò che provo veramente in ogni relazione non quel che la relazione è come cosa significata. Nessuno sa come ti amo veramente, neppure tu amo lo saprai mai. Non si può mai sapere, perché sempre viene sempre al sapere che procede su corpi di significati, che ferma, ratifica, archivia. I significati si giustificano alla trasmissione, poi pero vanno rivissuti per essere compresi. Il sapere si trasmette, la verità invece si prova. Il sapere è certo quel che è stato provato, è saputo, ma poi si prova a propria volta e non si può sapere quel che si viene a sapere. Così Platone parlava nel Sofista dell’essere, dicendo che quelli che ci hanno preceduto e che gli hanno dato un significato, non si sono poi preoccupati di noi che seguivamo e che non riusciamo a sapere la verità di quel che hanno saputo. In quel dialogo si legge che dobbiamo “provarlo” noi direttamente. Dobbiamo farne esperienza, si potrebbe dire, se non fosse che il termine usato da Platone è “paschein”, dobbiamo averne passione. Patirlo no, se non come sentirne la passione, provarlo, sentirlo. Senza farne una proprietà, senza cadere nella raccolta di quel che altri hanno saputo e lasciato. Noi dobbiamo certo raccogliere quel che è caduto nel sapere di quanto ci hanno preceduto, siamo sulle loro tracce, ma continuiamo poi un cammino, lasciando a nostra volta altre tracce di sapere, altri segni scritti, che altri capiranno veramente solo facendoli propri. In un possesso senza proprietà. Innamorati. In amore e in verità, in amicizia e verità. In relazione di verità. Non sarà come squarciare il velo. Il vero è il velo. Mi viene da pensare anche al Cristo velato, è una scultura, come sapete, si trova in questa città. Il Cristo è però velato non da un velo visibile, perché il velo del vero non è che si possa prendere tra le mani e dire ecco è fatto di questa materia. La materia del vero è il sentire e i sentimenti sono fatti di tempo. Quel velo è invisibile, il Cristo è velato del suo operato, è la sua opera il velo del vero del suo essere quel che è.
Il bene che rivela la bellezza
Quale dunque i velo del vero? Entra adesso nella composizione dell’opera dell’artista e della creazione dell’amante. La verità dell’opera, la verità della creazione, l’artista è amante e l’amante è artista. Il desiderio, il vero, il velo è lo stesso. Che cosa muove e vuole l’amante e l’artista? Si può rispondere: la bellezza. La felicità stessa è bella. La bellezza è felice. Ci stiamo allora meglio avvicinando all’arte della felicità. La stessa della bellezza, dell’artista e dell’amante. Forse chi è felice ama e crea, è un artista e un amante insieme. La bellezza dunque. Non c’è niente di più separato da noi che la bellezza. Separa. La bellezza è separazione. Il bello non che il tremendo al suo inizio si legge nella seconda Elegia di Rilke. Giusto all’inizio. Il bello non che il tremendo al suo inizio. La bellezza separa. La bellezza è divina. Si stacca, si separa da tutto il resto, diventa irraggiungibile al proprio sguardo che la mira. La bellezza è un pazzia, disse Lorenzo nel corso di bambini in filosofia. La bellezza è una pazzia, dura fin quando la trattieni. Poi sfugge, come la verità. Stanca addirittura, si può affermare. Eppure è la bellezza che suscita il desiderio e l’audacia di soddisfarlo. Chi la cattura e ne fa una proprietà ne resta prigioniero e perde la libertà. L’artista può diventare vittima della bellezza dell’opera quando la vuole tutta per sé. Così l’amante, resta prigioniero della bellezza di chi ama quando la pretende come sua proprietà.
Platone, ancora, nel Simposio dice della bellezza come esposizione dell’educazione amorosa. C’è però quel passaggio assai inquieto quando Diotima chiede a Socrate a che gli uomini desiderano la bellezza. Per averla per sé, risponde Socrate. Diotima però incalza, gli chiede ancora perché, a che pro gli uomini desiderano la bellezza per sé. Qui Socrate resta basito. Non sa rispondere. Lo confessa. Diotima allora dice di rispondergli sostituendo la domanda. Invece della bellezza può rispondere del bene. A che gli uomini desiderano il bene. Ecco, Socrate su questo sa rispondere, aprendo il varco al passaggio che arriva a fare strada all’educazione amoroso. Il bene è conservare la vita, generare. Qui posso aggiungere come noi che siamo mortali siamo capaci di parole eterne. Ecco noi che sia finiti possiamo generare e conservare a questo modo la vita, secondo un’immagine mobile dell’eternità, come si leggerà nel Timeo.
Diotima vela così l’arcano del bello. La bellezza è divina, il bene è umano. La bellezza sfiorisce senza il bene. Al punto che il bene rivela la bellezza custodendola. Noi dobbiamo pensare che chi ama svela nel bene il bello invisibile di ciò e di chi ama. La bellezza si rivela nel bene. Si vela del vero del bene. Pensate a quelle città in Europa che hanno una sola cosa bella e che ci costruiscono intorno tanta attenzione e tanto bene che la rivela quella bellezza, le danno velo, la rendono anche intoccabile. Pensate invece alla nostra città che di bellezza ne ha tanta, bellezza divina, bellezza natura, ma che intorno non le si costruisce il bene, non la si custodisce, la si violenta e perde.
Il bene è gratuito, dicevo, il male è banale. Alla banalità del male si oppone la gratuità del bene. Il male si fa, il bene si dà. Bisogna darsi nel bene. Il bene è un dono che lega al bellezza, che lo rende appunto gratuito. È il nodo del dono. Un legame di libertà. Il bene è il legame della bellezza. È separata la bellezza. Se dico di amarti sei bella e sei sconosciuta non riuscirò mai a sanare e soddisfare il desiderio, sarò pero libero, continuerò a desiderarti, desidero la vita che il tuo desiderio mi suscita riempendo di vita la mia esistenza. Il desiderio non è — come si dice — “mancanza”, se non quando si svuota l’esistenza che quando ama si riempi di vita nel bene di chi si ama. L’arte della felicità è quest’arte del bene che custodisce il bello, dando velo di vero a quel che si verrà sempre a sapere e non sarà mai saputo, come la vita. La felicità è come la libertà che viene dal desiderio. Nessuno è libero da solo, la libertà è fatta di legami. Anche chi è felice non lo è da solo, la felicità è fatta di legami. Quello più importante di cui ogni altro è significante è il legame tra il mondo e la vita. Quello tra la vita che si ha e la vita che si è. La vita è bella quando l’esistenza nel bene la rende tale. La vita è bella quando il mondo la rende bella, quando il mondo è buono ed è bene vivere.
L’arte della felicità è la stessa della libertà. È la stessa che rende l’artista amante e l’amante artista. Libera il desiderio nel vero del velo che dice di un sapere che non arriva dopo, ma che vive nella sconosciutezza della vita. Sul sacrario della vita, sul confine tra il mondo e la vita. Alla fine si può chiudere dicendo che l‘arte della felicità è mettere al mondo la vita e dare vita al mondo. La felicità non si deve raggiungere, bisogna preservarla. È la vita.
La Scuola d’arte e filosofia “Filosofia Fuori Le Mura” di Napoli presenta il progetto “BAMBINI IN FILOSOFIA” a cura del Professore Giuseppe Ferraro.

Intervento di Giuseppe Ferraro al Convegno “Disattendere i poteri – Pratiche in movimento – Sguardi filosofici” tenuto a Genova il 16 gennaio 2011 al Palazzo Ducale su iniziativa di Comunità San Benedetto al Porto di Genova in collaborazione con Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica.
Desiderio e bisogno
Le cose inutili sono quelle importanti, quelle utili sono necessarie, tanto più tali se rendono possibili quelle importanti. E come nel rapporto tra necessità e libertà. Noi in fondo ci occupiamo delle cose per le quali non c’è tempo, non c’è finanziamento, non c’è cura. Chi opera nel volontariato cammina sul ghiaccio della indifferenza. Lo apre. Incontra le persone nella singolarità del loro mondo. Chi fa volontariato tesse nodi di doni, unisce mondi differenti, genera le mappe del bene comune. Le cose utili, certo, sono necessarie, ma senza l’inutile carezza vera di una mano, senza la voce di una parola vera, la necessità è un rifiuto della libertà.
Non si può dire di un uomo che è reale se non ha un ideale di umanità. Sarà come cosa che cade, che accade, non sarà come chi vive per esistere in un mondo felice. La parola è la mano che si dà nella cura della vicinanza, dove c’è sofferenza provata, vissuta, inferta e subita. La parola avvicina, fa mondo, restituisce vita.
Le cose utili rispondono al bisogno, quelle inutili al desiderio, ma è solo questo, il desiderio, che stabilisce il grado di qualità della soddisfazione di un bisogno. Quando allora necessario diventa il desiderio, anche il bisogno diventa importante. Chi fa volontariato conosce questo passaggio, lo vive. Pratica un’economia interiore. Le cose che arrivano dalla volontà, vengono dal sogno di cui la vita ha bisogno per esistere felice. È come stiamo al mondo che è il mondo sta bene o male, felice o infelice. Siamo in mondo dove la crisi si coniuga al crimine, lasciando la critica resta senza ragione. La realtà è fatta di sentimenti, che poi sono le risonanze del nostro starci accanto. È come si è vicini che si è nel mondo che abitiamo. La prossimità è vicinanza.
Essere in prossimità significa trovarsi vicini a una metà, in raggiungimento del fine. Lo si intravede, si avvicina. Si può così essere in prossimità dell’arrivo di un viaggio. In prossimità del ritorno. Si è prossimi a quello che si sente. La prossimità è un sentimento rivolto a quel che si avvicina, che non si conosce, che sia ha dentro, si aspetta e non si sa come verrà, ci stupirà, ci darà più di quel che abbiamo pensato venisse, talora meno, solo per dare nuova spinta a raggiungerlo. Arriva dentro. Si ha quel che si da e quel. Be si riceve è un dono inatteso. La prossimità si coniuga allo sconosciuto, al non ancora venuto. Prossimo è il vicino, colui al un ti avvicini, ti cammina a fianco ed è prossimo, quando si rivela nella voce, quando ci si parla.
Toccare, risuonare
La mia esperienza è con i detenuti. Posso dire che è la stessa di ognuno che fa volontariato. Quando mi dicono che cosa fai portando la filosofia in carcere, dicono che ci tocchiamo, diciamo cose che ci toccano. Lo spiego meglio facendo la distinzione delle cose vere e delle cose certe. Da bambini, a scuola c’è un momento in cui s’impara ad imparare. Non è più il dettato o la copia e la lettura che c’insegnano. Arriva un momento che segna il passaggio dell’educazione a scuola. È quando la maestra ci spiega la differenza delle cose astratte e concrete. Nemmeno la maestra riesce a trovare modo ed esempio per la spiegazione di quella differenza. Quando poi si va a casa a completare il compito su quella distinzione, anche i genitori perdevano la linea di definizione. La maestra allora spiegava che le cose concrete sono quelle che si toccano e che le cose astratte sono quelle che non si toccano. Da bambino persi il cielo quel giorno. Altri rimasero e altri rimarranno increduli a dovere capire che ci sono cose che non si toccano, imparano forse la nostalgia o chiameranno dopo con questo sentimento l’intoccabile. I bambini toccano tutto. È difficile per loro intendere quella spiegazione. Poi ecco che magari qualche giorno dopo, quella stessa settimana, i genitori gli diranno che andranno a casa dei nonni e là non si tocca nulla. Il bambino capirà ancora meno la distinzione per una casa astratta. In realtà quella spiegazione è l’educazione alla proprietà. Quello che è tuo puoi toccarlo, quello che non è tuo non devi toccarlo.
Da grandi poi si comprende quell’altra distinzione, tra le cose certe e le cose vere. Quelle certe di toccano, quelle vere ti toccano. Così quando diciamo dell’amore vero e della vera amicizia, così quando diciamo del capire veramente qualcosa, del vivere veramente qualcosa. Capiamo che in quel “vero” è il proprio, il risuonare di quel che ci tocca e ci viene in contro. La prossimità è già una parola che risuona, è risonanza. Quando mi chiedono cosa facciamo tenendo corsi di filosofia coi detenuti, rispondo che ci tocchiamo, risuoniamo di quel che vero, lo sentiamo, la comprendiamo come nessun altro potrebbe capire, perché l’assoluto è singolare. A chi chiedesse a un giovane che è nel volontariato che cosa fa nella sua pratica, potrebbe sentirsi la risposta di quel “lo tocca”. Quando vedo la notte chi porta calore al barbone, chi lascia la coperta e il cibo a chi è caduto dall’altra parte del mondo, capisco che lo fa perché gli tocca, scambia la sua felicità interiore con la sofferenza dell’altro, lo rende felice prendendosi la sua sofferenza, ma come per valore la sofferenza vissuta e la felicità data non si scambiano di posto, ma si mischiano all’incontro. Il dolore è ancora amore. Chi non ama nemmeno prova dolore per ciò che si smarrisce e perde cadendo via dal mondo. Chi opera di volontariato acquisisce una memoria di ricordi, sono nodi di doni. Chi dona sente ritirarsi all’istante la sua mano, perché il dono è come ciò che non gli appartiene, è dell’altro, avuto altrove, una restituzione di quel che è come di nessuno e di ognuno, la vita intera, semplice, pura, la vita di nessuno, viene da dietro il mondo, reclama di esistere, viene fuori, cerca nel mondo la custodia, il suo riparo, l’etica dovette essere questo un tempo ed è solo questo ancora, dare mondo alla vita.
Vistiti di prossimità
La prossimità si vive addosso. Ne senti la gioia quando è la prossimità di una festa, ne senti l’ansia quando è la prossimità di un esame, anche il sentirsi ad agio o inebriato quando la vicinanza è al mare o al montagna che si preferisce. La prossimità è la sensibilità. La senti addosso. Non è una misura di spazio o di tempo che possa essere calcolata con strumenti e passi, la prossimità è dello spazio e del tempo interiore, cammina dentro gli spazi infiniti dell’animo. La prossimità è l’altro che la attiva, indica sempre quel che tocca di uno a un altro, di sé e dell’altro. Senza si resta soli, quando si sente dentro non porta confusione. Fa sentire sé dall’altro, non essere l’altro. La prossimità è il “quasi” di ogni relazione che dice della distanza invisibile e della differenza impercettibile dall’altro. Così un padre potrà essere “quasi” amico del figlio, ma “senza” essere amico perdendo la funzione paterna. Così, la maestra è “quasi” madre del bambino, ma non può essergli madre senza perdere la sua azione insegnante. Così anche un amico è “quasi” fratello e senza esserlo. Il “quasi” si dà allora nel “come”, nell’essere “come” l’altro, “con” l’altro. “Comis” in latino si dice dell’essere “cortese”, gioioso”, in altre lingue latine indica l’essere “impegnato”. Ed è l’essere “come” l’altro un impegno di se stessi. La prossimità in questo modo dice dell’empatia. Del sentirsi come l’altro, vicino. Non lo stesso, ma “quasi”. L’empatia non potrà mai dire di sé e dell’altro come uno, ma di una singolarità accanto a un’altra. La prossimità è come diceva il filosofo, Nietzsche, il nostro starci accanto cogliendo una differenza, quella ci permette di non confondere, quella che ci permette di capire l’altro da dentro, come quel che viene, come quel che inventa il nostro essere come siamo. L’altro inventa il mio animo, mi viene incontro, mi tocca dentro, mi fa sentire come sono, quasi come sento e sono. Io Altro. Proprio e improprio. Questo scarto interiore è la prossimità.
Legami di separazione
In questo scarto colgo una separazione e un legame. Lego me stesso all’altro, legandomi a quel che sento proprio e non è proprio, resta improprio. Qualcosa che capisco dentro me stesso quando dialogo, quando cerco un legame dentro me stesso, sentendo una separazione, dentro. Siamo vita e abbiamo vita. Questa la separazione che ogni legame mantiene e fa sentire. Siamo vita come viventi e abbiamo vita come esistenti. La vita che siamo ci è impropria, è la stessa di ogni altro vivente. La che abbiamo invece è nostro, propria, sono le nostre scelte, i progetti, le cose che ci procuriamo. Ci sono due forme di cura che si avvicendano in questa separazione. Ogni lingua europea la sostiene, il greco dice “zoe” e “bios”. In italiano si dice “vita” ed “esistenza”. Non sempre stanno insieme, se non per un legame, per la persona che amiamo, per la quale diciamo “sei tutta la mia vita” e che ci “riempie” l’esistenza di vita e senza sentiamo che resta vuota. La felicità è l’esistenza piena di vita. La sentiamo in ogni legame che ci restituisce la vita e il mondo insieme. Ogni legame è significante di quello più importante che lega la vita all’esistenza. Ne fa sentire la prossimità. Sono i legami di prossimità che significano quello più importante di esistenza e vita in ognuno. Ogni legame dice di una separazione. Ogni prossimità dice della presenza dell’altro, di un’altra, di altro. Così come si è prossimi a un altro mondo nella prossimità di un altro che viene, di un’altra.
Nodi di doni, l’esistenza e la vita
Ogni legame dice della separazione che mantiene. Legarsi è mantenere la separazione. Senza, arriva la confusione cui segue la delusione. Ogni legame mantiene la separazione, la tiene. Legarsi è dare manutenzione al rapporto di esistenza e vita, del mondo e della vita. Tenerli insieme è la prossimità dell’altro che viene, dell’altra che viene ed è, perché ogni essere è venuto al mondo, al nostro mondo. L’essere ha nel venire il suo cammino, la sua origine smarrita che si ritrova sono nell’altro che l’accoglie.
C’è la gratuità nel dono. C’è gratuità in ogni legame che si nodo di dono. Si lega restando sciolto. Sono i legami di libertà. Nessuno è libero da solo. La libertà è fatta di legami. Il grado della propria libertà è dato dalla qualità dei propri legami. Anche un paese, come l’Italia, è libero al grado della qualità dei legami sociali. Quanto maggiore è la qualità dei legami sociali tanto maggiore è la libertà di un paese. Il grado di democrazia si misura dai legami di libertà.
L’umano è gratuità nella prossimità. Un gesto che si dice “umano” è anche gratuito, senza interesse alcuno. La gratuità è nell’emergenza. L’umano emerge. Si dà nell’emergenza del bene. L’emergenza è il pericolo, lo stato in cui si rompe il legame tra la vita e l’esistenza. Allora l’umano emerge, perché il bene che si dà è nell’emergenza, quel che emerge. Il bene si dà, il male si fa. Nel darsi del bene non c’è un fare strumentale. Viene. Si sente dentro. Viene da dentro, come l’altro viene da fuori. Chi è nella vita e chi nel mondo non è dato identificare se non in un’identificazione che scambia l’uno e l’altro, come ogni amante è amato e ogni amato e amante. Può accade che ci sia una rottura, che l’amato non sia amante e che l’amante non sia amato. Allora bisogna essere l’uno e l’altro nel pieno dell’amore che si prova per l’altro. Essere amato dell’amore che si porta all’altro, perché chi ama è amato dall’amore che gli viene per l’altro dall’altro che lo fa venire in se stessi. Anche la terra lambita dall’onda del mare non è mare, ma sa del sale dell’acqua che la bagna, ne è impregnata.
La prossimità dice di tutto questo. Dice della gratuita, perché l’umano è gratuito, come l’amore è gratuito. Si fa dono della vita. È inutile, perché è importante e rende necessario quel che è utile. La prossimità è l’uso dell’umano. L’uso di sé nell’altro e dell’altro in se stessi. Non c’è utile senza l’altro, non c’è inutile senza sé. È quando allora ci si sente “inutili” che bisogna essere se stessi, andare dall’altro, venire a sé dall’altro, perché lo Stesso che compie il Sé è il ritorno che l’io fa dentro come “se stesso”. Si ritorna sempre dall’altro, dall’altra. Da chi viene.
Basta un gesto, non sapremo nemmeno cosa varrà per un altro. Non lo sapremo mai. L’altro è il nostro non sapere di quel che sappiamo, l’altro è la nostra solitudine. La prossimità conosce questa solitudine. Chi è nel volontariato la conosce più di altri. La nostra volontà è sola, quando è volontà di vivere.
Economia della prossimità
Senza questa premessa la prossimità diventa una misura, un calcolo sbagliato. Bisogna pensarla come l’economia della volontà di vivere, come economia del desiderio che dà qualità al bisogno. L’organizzazione del bene è l’espressione di un’economia che risponde al crimine della crisi. L’impresa sociale risponde al crimine della crisi di una cancellazione dello stato sociale. La spending review, la revisione di spesa di questi anni ha sostituito l’espressione del welfare, dello stato sociale. Invece di una revisione di spesa rappresenta un taglio di spesa, un prosciugamento progressivo della funzione sociale dello stato, dell’assistenza come della prossimità ai cittadini. Lo Stato è lontano, distante. L’istituzionale e il sociale sono lontani. La misura maggiore è della scuola per la quale la distanza del curriculo istituzionale è distante dalla vita sociale. Ed è una distanza resa ancora maggiore quando si vuole che la scuola sia legata al lavoro. Ciò significa che nella crisi dell’economia post industriale si vuole fare della scuola una fabbrica, come già accade per l’università e per gli studi che devono espressione d’innovazione essi stessi inseguendo un futuro che si allontana e un presente che è assente. Sono i giovani che non hanno futuro a mantenere nel presente il legame tra il mondo e la vita. Allora ecco le imprese sociali. Sono quelle che prendono il posto dello stato sociale e devono potersi moltiplicare sui territori facendo economia di comunità ciò che s’intende anche dicendo economia di prossimità.
Le associazioni di volontariato rispondono ha questa esigenza di mancanza dello stato sociale, ma non posso sostituirlo, non posso farlo. Deve poter essere altro proprio in ragione di una economia della prossimità che è il contrario di una economia della proprietà. Non è questione di dispendio, si tratta di un’operosità diversa. Fuori della proprietà e fuori dalla produzione, fuori dalla formazione. L’economia della prossimità è generativa. È quella che genera legame, quello più importante di portare la vita al mondo e dare mondo alla vita.
Comunità sociale e società comune
Lo Stato, da troppi anni ormai, non è lo Stato Nazione. Non è data Una Comunità d’appartenenza in cui riconoscersi per nascita. È cambiata la stessa portata della relazione di comunità e società. Lo Stato ha a che fare con più comunità, deve garantire adesso la società delle comunità. Il “male” delle nostre terre, l’Italia del Meridione, può diventare il “bene” da ritrovare. La cultura dell’Italia del Meridione è fatta di comunità che non sempre trovano espressione di società, perdendosi in forme “associazioni” devianti. Questo “male” deve cambiarsi nel bene. Lo Stato è chiamato a garantire il rapporto tra società e comunità, questa la sua funzione istituzionale. La crisi è di una distanza tra società e comunità. Il volontariato, quello che si chiama terzo settore è chiamato a mettere in rapporto società e comunità. È chiamato a istituire imprese sociali di comunità. Le associazioni di volontariato devono diventare delle comunità esse stesse, in una prossimità costante di società e comunità, senza confondere l’una con l’altra, facendosi prossime di altre imprese sociali comuni.
Il compito è di attivare una società comune in una comunità sociale. È un’economia interiore per una comunità interiore di cui sola è capace la prossimità di generare. Si tratta di un’altra economia quella che non distingue l’utile dall’inutile perché non sia distinto il bene come materiale d’uso e proprietà dal bene come valore di prossimità senza proprietà. La distinzione non è tra materiale e immateriale, perché una tale distinzione nell’uso che se ne è dato ha reso l’immateriale ancora più materiale, facendo del desiderio un prodotto da acquistare in rete.
L’economia della prossimità è senza proprietà. Il suo principio è la restituzione. Bisogna restituire come dell’altro quel che si sente propriamente di sé. È la restituzione della vita. È un’economia non produttiva, ma generativa di una società comune per una comunità sociale.
Il disagio della volontà, governare l’esistenza
Non vivere secondo le attese, ma secondo gli incontri. La comunità sociale è l’esposizione di una comunità interiore. Il volontariato in Italia ha sostituito non solo lo stato sociale che si è prosciugato nel corso degli anni, ma ha sostituito anche la contestazione politica e l’agire conseguente che reclamava dalle istituzioni ciò che esse già non potevano più promettere. Si trattava di agire per un’attesa che si sapeva già delusa, per cui l’agire politica si chiudeva su se stesso. Il terzo settore è stato il canale che si è voluto offrire all’agire politico sociale e spontaneo. La diffusione dell’associazionismo per un verso ha richiamato su un piano istituzionale dal basso, venuto dall’emergenza che si è strutturato come servizio non governativo ovvero non istituzionale ma sociale. Accanto a questo è rimasto il volontariato di movimento che si diffuso per luoghi e non per associazioni, identificandosi nei locali occupati piuttosto che nelle associazioni strutturate. La dimensione politica è presente e assente in un caso come nell’altro. Ciò che risponde ad una nuova forma politica di partecipazione diretta. Se la prossimità indica l’essere vicini ad un mondo diverso dentro quello esistente, anche la politica ne partecipa e diventa politica della prossimità. Ancora una volta politica di prossimità a una società comune per una comunità sociale. Tante comunità sociali per una società comune.
Se vale il “postliminio”, la ripresa in modo diverso della dimensione politica di partecipazione, al fondo è la condizione esistenziale di volontarietà che la sostiene. Una condizione esistenziale che trova nella precarietà la propria dannazione e la leva della propria esposizione. Chi è nel volontariato deve lottare contro se stesso e contro l’indifferenza della ordinaria quotidianità. Da una parte la contrarietà interiore e dall’altra la condizione reale. Di nuovo bisogna intendere è reale solo l’uomo che ha un ideale, diversamente non può chiamarsi vera l’umanità che ci si attribuisce.
Il disagio della volontà e nell’accettazione della sua impresa. Accettazione di sé e accoglienza dell’altro stanno insieme, l’una rende l’altra possibile in uno scambio di incontro inatteso. La possibilità che ne viene è la possibilità dell’impossibile, di ciò che non si poteva prevedere e calcolare. Le cose vere sono così. Sono impossibili. Bisogna fare l’impossibile perché siamo siano possibili. A sostegno viene quella che si dice “self reliance”, quella fiducia di relazione a sé, che è impossibile senza la prossimità, senza l’altro, l’altra della prossimità.
La volontà buona non è tale per ciò che essa fa e ottiene, … ma solo per il volere, in se stessa;… anche se il suo maggior sforzo non approdasse a nulla ed essa restasse una pura e semplice buona volontà […], essa brillerebbe di luce propria come un gioiello, come qualcosa che ha in sé il suo pieno valore. L’utilità e l’inutilità non possono né accrescere né diminuire questo valore. (I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi)